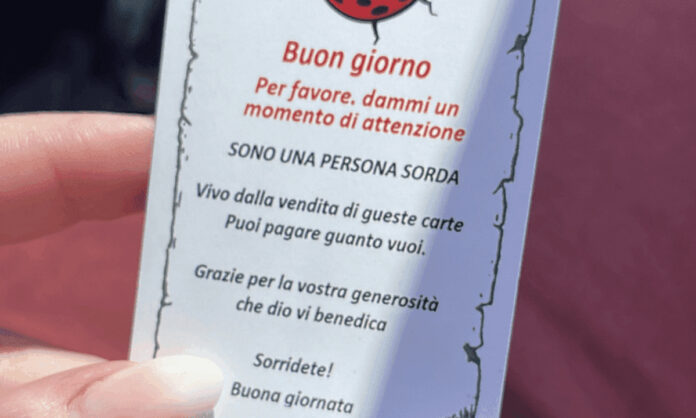Cosa sta succedendo, cos’è il Kashmir e quanto bisogna preoccuparsi: un breve ripasso di una storia lunga e complessa
Martedì sera l’India ha lanciato alcuni missili contro il Pakistan e il Kashmir pakistano, uccidendo almeno 20 persone. L’attacco, ha spiegato il governo indiano, è stato una ritorsione per l’attentato compiuto lo scorso 22 aprile a Pahalgam, nel Kashmir indiano. Il Pakistan ha promesso ritorsioni. È una storia complicata e le tensioni tra i due paesi, anche ma non solo per il controllo del Kashmir, vanno avanti da decenni. Abbiamo messo insieme dieci domande e risposte per capire un po’ meglio quello che sta succedendo, e quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.
1. Perché l’India ha attaccato il Pakistan?
Il governo indiano ha detto che i bombardamenti sono una ritorsione per gli attentati terroristici di aprile in cui erano state uccise 26 persone. L’India sostiene che il gruppo armato islamista che li ha compiuti, il Fronte della Resistenza (anche conosciuto come “Resistenza del Kashmir”), sia aiutato e sostenuto dal Pakistan, che ha sempre negato le accuse. Mercoledì, dopo gli attacchi, il ministero degli Esteri indiano ha detto che l’India ha fatto passare due settimane dall’attentato aspettandosi che il Pakistan facesse qualcosa contro il Fronte, e che ha colpito ora perché l’intelligence avrebbe scoperto che il gruppo stava pianificando nuovi attentati.
2. Il “Fronte della Resistenza” è appoggiato davvero dal Pakistan?
Non c’è una risposta certa e condivisa a questa domanda. Il Fronte della Resistenza è un gruppo piccolo e poco noto, designato come organizzazione terroristica dall’India nel 2023. Secondo l’intelligence indiana e diversi analisti è emanazione del più grande Lashkar-e-Taiba, che ha una storia di grossi attentati in India. Il Fronte aveva inizialmente rivendicato gli attacchi di Pahalgam con un messaggio sui social ma poi ha negato ogni responsabilità e disconosciuto la rivendicazione, sostenendo che fosse il risultato di un attacco informatico volto a screditarlo.
Il governo pakistano da tempo smentisce ogni appoggio economico o militare ai gruppi armati del Kashmir (che erano palesi invece negli anni Novanta), pur condividendone gli intenti e mantenendo una vicinanza di qualche tipo. Ha chiesto all’India di condividere le prove su cui basa le sue accuse: il governo indiano per ora non ne ha diffuse di concrete.
3. Perché esistono un Kashmir indiano e uno pakistano?
India e Pakistan nacquero dalla divisione, frettolosa e cruenta, dell’ex colonia dell’India britannica nel 1947, quando il Regno Unito decise di abbandonare l’area. I territori vennero divisi su base religiosa: quelli a maggioranza indù diventarono l’India, quelli a maggioranza musulmana il Pakistan. Il destino del Kashmir non venne deciso: la sua popolazione era prevalentemente musulmana, ma lo governava un re indù che per qualche tempo sperò di poter mantenere il potere in uno stato indipendente. Nel giro di qualche mese truppe pakistane entrarono in Kashmir, il re per tutelarsi acconsentì a far diventare il suo regno parte dell’India. Iniziò la prima guerra fra India e Pakistan, che nel 1949 si chiuse con una divisione della regione in due parti, controllate dai due paesi.
Da allora quel confine di 740 chilometri è rimasto lo stesso, così come le posizioni dei due paesi, che reclamano l’intera regione. La parte indiana godeva fino al 2019 di una ampia autonomia che le è stata poi revocata dal governo del primo ministro indiano Narendra Modi. A complicare il tutto c’è una parte del Kashmir, quella occidentale, controllata e amministrata dalla Cina: ci sono ricorrenti schermaglie e accordi non sempre solidissimi con l’India anche lì.
4. Come stanno raccontando la crisi i giornali locali
I media indiani la chiamano “Operazione Sindoor”, il nome scelto dal primo ministro Narendra Modi. Significa “vermiglio” in lingua hindi ed è il colore di un pigmento che le donne induiste utilizzano come simbolo del matrimonio: è un riferimento al fatto che negli attentati gli uomini sarebbero stati uccisi di fronte alle loro mogli.
Il racconto dei media indiani e pakistani è agli antipodi ma ugualmente polarizzato. I primi si concentrano sull’obiettivo di «antiterrorismo» dell’operazione e sostengono la narrazione del governo: per esempio l’Hindustan Times ha una mappa delle «nove infrastrutture terroristiche» colpite e India Today elogia «l’arte dell’inganno» di Modi, cioè la tattica d’aver colpito a sorpresa. I secondi titolano sui «raid notturni codardi» (la tv privata Geo). Il Daily Jang, principale giornale in lingua urdu, celebra l’abbattimento di cinque caccia indiani scrivendo: «l’India ammette la sconfitta alzando bandiera bianca» mentre Dawn, il più autorevole e in lingua inglese, fa una copertura più sobria e basata sulle fonti istituzionali.
Un post propagandistico dell’esercito indiano con il nome dell’operazione
5. Perché India e Pakistan non vanno d’accordo?
Per una serie di motivi, le cui radici sono nella partizione del 1947, nel caos, nelle migrazioni e nella violenza che seguirono. Il Kashmir è il terreno di disputa principale, ma non l’unico. Le differenze religiose sono il motivo di distanza maggiore, soprattutto da quando l’India di Modi ha abbandonato l’approccio da stato laico e multireligioso, rendendo l’induismo sempre più religione “di stato”.
L’India da decenni accusa il Pakistan di finanziare il terrorismo islamico e i movimenti indipendentisti, il Pakistan considera l’India un pericolo per la sua esistenza da quando nel 1971 intervenne nella guerra di liberazione del Bangladesh (allora una parte del Pakistan, poi stato indipendente). Altri motivi di tensione riguardano lo sfruttamento delle risorse idriche e il posizionamento nei conflitti regionali e nelle alleanze con le potenze globali.

Sostenitori pakistani della Lega musulmana Markazi bruciano una bandiera indiana a Peshawar, per protesta contro gli attacchi (AP Photo/Muhammad Sajjad)
6. Quante guerre hanno combattuto i due paesi?
Cinque guerre maggiori, e una lunga serie di schermaglie, attacchi e bombardamenti limitati o dimostrativi. Dopo quella del 1947, ci sono state altre tre guerre in Kashmir, nel 1965, nel 1984 e nel 1999: la prima non cambiò i confini, le ultime due consolidarono limitatamente le posizioni indiane. In mezzo ci fu la guerra legata all’indipendenza del Bangladesh: nel dicembre 1971 l’intervento indiano fu risolutivo e dopo due settimane di intensi combattimenti l’esercito pakistano si arrese (90mila soldati pachistani furono fatti prigionieri).
Le crisi al confine più recenti e rilevanti sono quelle del 2016, con l’intervento di forze speciali indiane; del 2019, con bombardamenti aerei indiani; e del 2021, con scontri a fuoco lungo il confine.

Soldati indiani pattugliano il confine col Pakistan sul lato indiano, nella regione del Jammu e Kashmir (AP Photo/Channi Anand)
7. La situazione attuale è diversa e più preoccupante?
Al momento non ci sono grandi motivi per ritenere che i due paesi vogliano davvero una guerra su larga scala: negli ultimi decenni, dopo attacchi terroristici di gruppi o movimenti islamici, i vari governi indiani hanno alimentato la retorica anti Pakistan e spesso condotto con toni molto aggressivi attacchi limitati. In questo caso l’India ha definito i suoi attacchi «misurati, responsabili e concepiti per evitare una escalation», sostenendo di aver colpito strutture «legate al terrorismo». Il Pakistan vive un periodo di sostanziale debolezza, soprattutto interna, e sembra avere ancora meno interessi a essere coinvolto in una guerra ampia, nonostante i proclami.
8. Le forze militari dei due paesi sono simili?
Quelle dell’India sono superiori, per numero di soldati, spese, mezzi e tecnologia. Il Pakistan ha comunque forze militari in grado di esercitare deterrenza e più concentrate su un territorio minore. Soprattutto, entrambi i paesi hanno armi nucleari, stimate in circa 170 testate ognuna.

La parata dei soldati indiani e pakistani durante la cerimonia giornaliera di chiusura del confine, al varco di Wagah, il 5 maggio (AP Photo/K.M. Chaudary)
9. Chi governa India e Pakistan?
In India dal 2014 il primo ministro è Narendra Modi, del partito Bharatiya Janata Party (BJP): è al terzo mandato, il BJP è un partito conservatore, liberista in economia, fortemente nazionalista e che si presenta come difensore della religione indù, anche discriminando le minoranze religiose. Durante il governo di Modi, l’India ha ottenuto buoni risultati economici, ma senza redistribuzione delle ricchezze e riduzione delle diseguaglianze. È anche diventata un paese più autoritario, con minori libertà personali e di espressione.
Dal marzo del 2024 in Pakistan il primo ministro è Shehbaz Sharif, della Lega musulmana del Pakistan (PML-N), di centrodestra, a capo di un governo di coalizione con il Partito Popolare Pakistano (PPP), di centrosinistra, suo storico rivale. L’accordo escluse chi aveva vinto le elezioni, il Movimento per la Giustizia (PTI) dell’ex primo ministro nazionalista e populista Imran Khan, in carcere per diverse condanne per corruzione (i candidati si erano presentati come indipendenti perché il partito era stato dichiarato illegale). Le dispute intorno a Khan e alla sua detenzione, che i sostenitori ritengono politicamente motivata, continuano a essere centrali nel dibattito pubblico, l’esercito ha un enorme potere politico ed economico e il paese vive da anni una profonda crisi economica.
10. Con chi stanno Stati Uniti e Cina?
L’India è un interlocutore importante per gli Stati Uniti in chiave anticinese, anche se negli ultimi mesi ci sono state diverse tensioni tra i due paesi. Tra Modi e il presidente Donald Trump c’è comunque una certa sintonia politica, confermata anche da proficue trattative sulla questione dei dazi.
Il Pakistan è stato uno storico alleato degli Stati Uniti, che lo ritengono tuttora un partner nella lotta al terrorismo, ed è stato sia una loro base operativa durante i vent’anni della guerra in Afghanistan sia il posto dove le forze speciali statunitensi uccisero l’ex leader di al Qaida Osama bin Laden.
La Cina ha migliori rapporti col Pakistan, anzitutto economici, mentre è una rivale regionale dell’India, con cui ha un’annosa disputa territoriale sul confine himalayano (recentemente ci sono stati progressi). Entrambi i paesi hanno condannato l’attacco indiano, comunque senza schierarsi e auspicando che la crisi rientri: Trump l’ha definita «una vergogna», il governo cinese «deplorevole».
(11) Bonus. Quali gruppi armati sono attivi in Kashmir?
Vari. Come detto il principale è Lashkar-e-Taiba che significa “l’esercito dei puri” ed è stato fondato nel 1990: il Pakistan l’ha messo fuori legge nel 2002, su pressione internazionale, e nel 2019 ha condannato il suo fondatore Hafiz Saeed a 31 anni di carcere. C’è anche Jaish-e-Mohammad (“l’esercito del profeta Maometto”), che ha legami con i Talebani e al Qaida. Mercoledì l’esercito indiano ha detto d’aver colpito anche sue basi e il fondatore, Maulana Masood Azhar, ha confermato che gli attacchi hanno ucciso dieci membri della sua famiglia: i media indiani hanno dato grande risalto alla cosa. Altri gruppi hanno perso influenza nel corso del tempo: tra loro Hizbul Mujahideen, da cui è nato un sottogruppo chiamato Al Badr. Infine c’è Ansar Ghazwat-ul-Hind, l’affiliato locale di al Qaida. E poi il Fronte della Resistenza, al centro di questa crisi: a differenza degli altri, ha un’impostazione laica e anche il nome non ha riferimenti all’Islam.